|
<6> QUI C’ERA LA
PIEVE DI S. GIOVANNI
Un pomeriggio del mese di gennaio 2012 accompagnai la
ragazza polacca dall’arciprete della Collegiata Mons.
Andrea Cristiani perché aveva bisogno di un suo consiglio.
Giunti a piedi in piazza Garibaldi, costeggiammo la
facciata del Palazzo Montanelli - quello dove morì
Giuseppe Montanelli (1862) e dove nacque Indro (1909) - ed
entrammo sul Poggio Salamartano fermandoci proprio davanti
all’imbocco delle “Scarelle” dove nel 1300 c’era la porta
della Porticciola. Suonai il campanello degli uffici della
parrocchia.
Venne ad aprirci Stefano Boddi, il segretario.
- Desiderate? – ci chiese.
- Questa ragazza polacca desidererebbe conferire qualche
minuto con don Andrea – risposi.
- Sentite, in questo momento sta parlando con il titolare
di una ditta. Ne avrà per una ventina di minuti. Se volete
potete accomodarvi qui nell’ingresso: altrimenti potete
ritornare fra una mezz’oretta.
- Aspetteremo qui fuori al sole – gli dissi.
Ci portammo al vicino parapetto del muro castellano dove
avremmo potuto accostarci o sederci.
Margherita non si lasciò sfuggire la presenza sul grande
muro perimetrale della Collegiata di una porticina, messa
a nuovo.
- E questa porticina? – chiese.
- Porta direttamente sul presbiterio della chiesa, ma
viene tenuta sempre chiusa perché i ladri in più occasioni
si sono serviti di questa porticina per entrare in chiesa
e derubarla.
- Ma quanto è alto questo muro! E quella specie di
quadrato lassù in alto?
- Era la meridiana che segnava le ore del pomeriggio.
Presto verrà ripristinata. Questo muro alto non è altro
che la spalla della chiesa Collegiata che guarda nella
Piazza…Vittorio Veneto.
- Peccato che questa spalla della Collegiata si avvicini
troppo al muro castellano - osservò Margherita.
- Cara Margherita, fino all’anno 1800, qui c’era uno
spazio molto più largo e al posto di questa spalla, ma
molto più indietro, c’era la facciata della vecchia Pieve
di S. Giovanni che venne demolita completamente nell’anno
1783.
- Ma cos’era la Pieve? – mi chiese Margherita, maglietta
nera e jeans bianchi.
L’immagine della Pieve comparve sul display
- Tieni. Il display del cellulare magico ti mostrerà la
Pieve di S. Giovanni Battista e capirai.
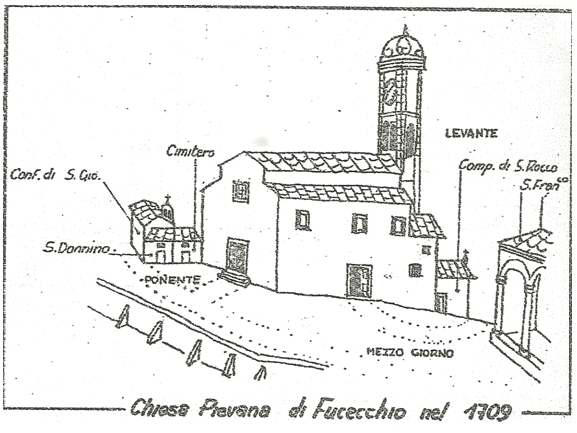
Margherita osservò attentamente l’immagine disegnata da un
sacerdote dell’epoca, certo Tondoli, e poi , sorpresa
esclamò:
- Ma allora qui davanti a noi c’era la facciata di quella
che tu hai chiamato Pieve. Forse, forse, in corrispondenza
della porticina c’era la porta d’ingresso della Pieve.
Vedo che c’erano altre chiese nei suoi paraggi. Ma cos’è
una Pieve?
- E’ una chiesa, come puoi vedere.
- Ma perché viene chiamata Pieve?
- Non lo so. Domandalo a lei.
Margherita non se lo fece ripetere due volte: premette il
pulsante verde e chiese:
- Puoi dirmi, per piacere, che cos’è una pieve?
- Volentieri, dolce Margherita – rispose la Pieve con voce
molto chiara e pacata. Proseguì:
- Io venni costruita su questo colle dopo il Mille. In
questo cocuzzolo, ma anche nelle campagne vicine vivevano
alcune famiglie. Tutte furono felici quando questa chiesa
venne aperta. Finalmente potevano venire a Messa o alle
esequie dei propri defunti. Però quando nasceva un bambino
o una bambina i genitori non potevano battezzarli in
questa chiesa: dovevano andare a battezzare i loro figli o
alla Pieve a Ripoli – accanto alla Conad - o a Ponte a
Cappiano. Le chiese di Ripoli e di Ponte a Cappiano erano
autorizzate a battezzare. Io non ero autorizzata. E le
chiese autorizzate a battezzare si chiamavano, appunto,
Pievi.
- Siccome tu ti chiami Pieve di S. Giovanni, puoi dirmi,
per piacere, quando diventasti una pieve?
- Nell’anno 1088.
- Chi ti fece diventare una pieve?
- Il papa Urbano II.
- E per quale ragione?
- Perché glielo chiese ripetutamente il penultimo
feudatario fucecchiese, il cadolingio Uguccione. A lui
dispiaceva che i suoi sudditi dovessero fare quel viaggio
per battezzare i propri figli. Comunque, sappi, cara bella
Margherita, che questa pieve diventò una chiesa speciale
fino al 1622.
- Tu, cara Pieve, fai salire la febbre della mia
curiosità. Mi puoi spiegare perché questa Pieve diventò
una chiesa speciale?
- Vedi, Margherita, i preti di questa chiesa fino all’anno
1085 dovettero obbedire al vescovo di Lucca. A partire dal
1085 tutti i parroci che si sarebbero susseguiti uno
dietro l’altro in questa chiesa non avrebbero dovuto più
obbedire al Vescovo di Lucca bensì all’abate, cioè al capo
del monastero di S. Salvatore che si trova a due passi da
voi, quello dove ora si trovano le monache. A quel tempo
non c’erano le macchine e nemmeno il telefono e nemmeno i
treni. Prima del 1085,quando un parroco di questa chiesa
voleva imbiancarla o dare un nome ad un altare doveva
chiedere il permesso al vescovo di Lucca. Per ottenere il
permesso doveva andare dal vescovo a Lucca o scrivergli
una lettera. A quel tempo non c’erano nemmeno le
biciclette. L’unico mezzo di trasporto era il cavallo. Ed
il vescovo, molte volte, prima di concedere il permesso,
voleva rendersi conto di quello che effettivamente voleva
fare il prete di questa chiesa. Qualche volta mandava a
Fucecchio ad effettuare i controlli una persona di sua
fiducia (il vicario) o veniva lui medesimo. Tu puoi ben
immaginare le perdite di tempo che erano necessarie. Ma
questo è soltanto l’esempio di uno dei tanti problemi che
dovevano essere risolti con il consenso del vescovo.
Dopo il 1085 il parroco di questa chiesa, usciva dalla
medesima e in due minuti si poteva recare dall’abate e
risolvere immediatamente i problemi. A quel tempo nel
monastero c’erano i monaci vallombrosani.
- Ma anche gli attuali sacerdoti di questa chiesa devono
obbedire all’abate del Monastero?
- No, no. Dal 1622, e cioè da quasi 400 anni, i parroci di
questa chiesa devono obbedire al Vescovo di S. Miniato.
Non chiedermi perché, altrimenti questa storia non finisce
più. E tu ti stancheresti.
- La chiesa che ho visto sul display del cellulare non c’è
più. Perché?
- Perché un prete molto istruito di Fucecchio riuscì a
convincere il parroco di questa chiesa, il vescovo ed
anche il granduca che Fucecchio si meritava una chiesa
molto più grande e con la facciata rivolta sulla piazza
che era il cuore di Fucecchio.
- Ed allora che cosa successe?
- Nell’anno 1783 la chiesa che hai visto sul display ed
anche il campanile vennero demoliti e furono subito
allungate le fondamenta laterali.
- Ma eri piccola davvero?
- Non credo. Ero lunga 29 metri e mezzo; ero la larga 14
metri e qualche centimetro; ed ero alta 11 metri. Forse
davo l’impressione di essere più piccola perché ero a tre
navate spartite da un doppio ordine di 5 colonne di
pietra.
- Quanti altari c’erano e a chi erano intitolati?
- Ce n’erano 9 e cioè due di più di quelli che si trovano
nella chiesa attuale che è leggermente più grande. Al
centro del presbiterio c’era l’altar maggiore, l’unico in
stucco (gli altri erano in pietra), ornato di quattro
colonne, conservava il corpo di San Candido, patrono di
Fucecchio.
Nella parete destra c’erano quattro altari:
- l’altare del Santissimo Sacramento, sulla testata destra
dell’altar maggiore;
- l’altare del Nome di Gesù, sul quale era collocata una
Circoncisione (oggi perduta), opera del
fiorentino Cecco Bravo
- l’altare di San Sebastiano di patronato della faimiglia
Taviani;
– l’altare di patronato Paperini (ultimo a destra) su cui
era posta la tavola con la Madonna in
gloria con i Santi Sebastiano, Lazzaro, Maria Maddalena e
Marta, oggi al Museo civico, opera dello Scheggia.
Nella parete sinistra c’erano gli altri 4 altari:
- l’altare della Madonna del Carmine, con la tela
raffigurante la Vergine che consegna lo
scapolare a San Simone, con ai lati i Santi Antonio Abate,
Antonio da Padova e un santo martire, oggi al Museo civico
- l’altare del Crocifisso di patronato Gherardi ;
- l’altare di Santa Lucia su cui era posto il Martirio di
Santa Lucia con le Sante Apollonia e
Agata (ora in Collegiata nella cappella del Santissimo),
citato da Alessandro Peri come di sua
proprietà, nel 1802;
- l’altare di San Nicola da Tolentino dei Lavaiani, già
Aleotti, eredi della famiglia Magnani,
proprietari del quadro con la Vergine e i Santi Michele
Arcangelo, Nicola di Bari e Nicola da
Tolentino ,opera di Michele Laschi, oggi al Museo civico
All’arredo della chiesa appartenevano anche il fonte
battesimale e una acquasantiera cinquecentesca in marmo.
Essa fu venduta dall’arciprete di Fucecchio agli Operai di
S. Regolo nel 1787 per 14 lire. Oggi si trova nella chiesa
di San Regolo a Buggiano.
- Sei soddisfatta, Margherita?
- A dire il vero sono molto dispiaciuta. Ma ormai il
dispiacere e i rimpianti non servono più a niente. Vorrei
sapere però se quell’oggetto tondo che si trova sul
riquadro più alto del campanile è un orologio.
- Sì è proprio quell’orologio che il tuo accompagnatore ha
ribattezzato “girellone”. Mario ne ha scritto la storia
dall’A alla Z nel libro intitolato FUCECCHIO PARLA che
puoi leggere su Internet. Vi saluto entrambi perché
qualcuno sta per chiamarvi. Ciao, Margherita! Ciao, Mario.
Auguroni!
Si riaprì la porta degli uffici della Collegiata, vi si
affacciò Stefano che ci disse:
- Se volete, don Andrea può ricevervi.
S. Pietro Igneo 8 febbraio
Se il benemerito canonico fucecchiese Gaetano Maria Rosati
non avesse intitolato a S. Pietro Igneo il nostro
ospedale, inaugurato ufficialmente nel marzo del 1857,
nessun fucecchiese avrebbe mai venerato questo santo
monaco che ha esercitato un ruolo importantissimo nella
storia del nostro paese.
Fino agli anni '80 il giorno 8 febbraio era atteso
soprattutto da quanti erano ricoverati nel nostro
nosocomio: per S. Pietro Igneo il menù, festivo,
comprendeva perfino il dolce; e per tutto il giorno era
concesso il libero accesso ai visitatori.
Dopo la partenza delle monache del Cottolengo dal nostro
ospedale, avvenuta il 30 giugno 1983, la tradizionale
festa di S. Pietro Igneo è stata depennata per sempre.
biografia
Il futuro monaco vallombrosano nacque a Firenze nel
1010 dalla famiglia Aldobrandini.
All'età di 8 anni entrò nel monastero di Vallombrosa,
fondato e diretto da Giovanni Gualberto grazie all'aiuto
finanziario del nostro conte cadolingio Guglielmo il
Bulgaro che da Fucecchio si era trasferito a Badia a
Settimo.
Diventato adulto, Pietro partecipò con Giovanni Gualberto
alla lotta contro i due bubboni che avevano colpito il
clero cattolico: la simonia e il concubinato.
Nel 1068 Giovanni Gualberto accusò il vescovo di Firenze,
Mezzabarba, di essersi procurato il titolo di vescovo con
il denaro. Per comprovare questa sua affermazione,
Giovanni Gualberto si dichiarò disposto a far affrontare
da uno dei suoi monaci il Giudizio di Dio, cioè una prova
che richiedeva l'intervento di Dio.
Venne concordata la cosiddetta PROVA DEL FUOCO.
Fra i numerosi monaci disposti ad affrontare una simile
prova fu scelto Pietro che , allora, aveva 58 anni.
Due cataste di legna, lunghe mt 5,80 formavano un
corridoio strettissimo attraverso il quale il monaco
vallombrosano doveva passare illeso.
La prova si sarebbe svolta a Settimo, a sette miglia da
Firenze.
Il giorno della prova, Pietro celebrò la S. Messa, prese
la croce e, accompagnato dai confratelli, si avvicinò alle
cataste di legna a cui venne appiccato il fuoco. Il
monaco, allora, si inginocchiò e chiese a Gesù di
assisterlo.
Quando si rialzò, già le fiamme avevano invaso lo stretto
corridoio cosparso nel suo tracciato di braci ardenti.
Pietro, a piedi nudi, si infilò fra i due roghi, percorse
lentamente il corridoio ed uscì illeso dall'altra parte
acclamato dal popolo che gridava al miracolo.
Il monaco tornò indietro per passare una seconda volta fra
le fiamme, ma il popolo glielo impedì baciandogli i piedi
e strappandogli di dosso lembi di tonaca per conservarli
come reliquie di una creatura benvoluta da Dio.
Il vescovo Mezzabarba scappò subito da Firenze.
Per desiderio del nostro conte Guglielmo il Bulgaro, il
monaco Pietro venne mandato a Fucecchio a dirigere , come
abate, il monastero di S. Salvatore che a quell'epoca si
trovava in prossimità del ponte sull'Arno, detto di
Bonfiglio.
L'abate Pietro, detto Igneo per avere superato la prova
del fuoco, diresse la nostra abbazia dal 1068 al 1072.
Nel 1072 papa Alessandro II lo nominò cardinale e vescovo
di Albano.
S. Pietro Igneo, pur andandosene via da Fucecchio,
conservò sempre il titolo di abate del monastero di S.
Salvatore.
Quando, negli anni successivi, diventò collaboratore del
papa Gregorio VII ottenne per la nostra abbazia il
privilegio del NULLIUS DIOCESIS.
Con questo privilegio del 9 maggio 1085 papa Gregorio VII
decretò che " l'abbazia di Fucecchio con i suoi beni,
cappelle e possedimenti che aveva e che avrebbe avuto in
seguito dipendesse direttamente dalla Santa Sede che la
riceveva sotto la sua protezione".
Per effetto di questo privilegio, l'abate sarebbe stato
eletto dai monaci medesimi e l'abbazia sarebbe stata
indipendente dalle ingerenze di qualsiasi vescovo.
Questo privilegio si rivelò in seguito addirittura nefasto
per la crescita spirituale della comunità vallombrosana
della nostra abbazia.
Pietro Igneo morì nel 1089 in odore di santità ed in fama
di taumaturgo.
|