|
<3> ORATORIO DI S.
ROCCHINO
Dal mercatino domenicale a S. Rocchino
In Piazza Vittorio Veneto per tutto il 2011 vi svolse
settimanalmente il mercatino della domenica. Un amico mi
avvisò che quel mercatino aveva le settimane contate
perché gli insuesi neppure si accostavano alle cinque o
sei bancarelle che esponevano i loro pezzi. Addirittura
ben cinque delle cinque o sei bancarelle non si
presentavano più da circa un mese.
Decisi di andare a vederlo almeno per una volta.
Quella domenica mattina ci trovai soltanto una bancarella
con ortaggi e frutta. Davanti alla bancarella c’erano due
ragazzine in pantaloni neri e berretto nero a cuffia. Una
delle ragazze indossava una mantellina bianca con
guarnizione nera. Forse, questa, era la polacca
Margherita. Avevo indovinato.
- Ciao, Margherita – la salutai.
- Ciao, ciao, ciao, Mario! Che piacere incontrarti nella
Piazza del tuo paese. Chissà quante cose interessanti sono
sepolte sotto queste lastre di pietra!
- Hai perfettamente ragione. Comunque te le taccio perché
le troverai tutte quante nel mio libro FUCECCHIO PARLA. Di
una cosa sepolta, però, non ne parlai. Se mi seguirai ti
porterò proprio nell’area dove un’altra chiesina, detta
altrimenti Oratorio, vi venne realizzata e vi morì.
Margherita salutò il bancarellista e mi seguì.
Mi portai verso la scalinata in pietra che sale alla
Collegiata. Insieme a Margherita salimmo la prima rampa di
scalini e giunti sul ripiano feci cenno alla ragazza di
fermarsi. Spiegai:
- Proprio qui c’era una chiesina, l’Oratorio di S.
Rocchino. Ed ora prenditi il cellulare magico e divertiti
a rivolgere tutte le domande che desideri all’Oratorio
ormai sepolto.
L’Oratorio di S. Rocchino fornisce la prima rivelazione
Margherita prese il cellulare magico che avevo tirato
fuori dalla tasca del mio cappotto scuro e cominciò:
- Buongiorno, buongiorno, buongiorno, oratorio di S.
Rocchino.
- Buongiorno, Margherita. Sono contento che qualcuno si
interessi finalmente di me.
- Vorrei sapere subito se ti fece costruire il Comune di
Fucecchio.
- No. Non ci hai indovinato. Venni fatto costruire dalla
Compagnia di S. Rocchino che i fucecchiesi avevano
ribattezzato la Compagnia dei Pomposi. Vuoi sapere perché
li chiamavano cosi?
- No, no, no! Desidero sapere perché tu vieni chiamato
Rocchino. Forse esistono due santi; Rocchino e Rocco?
- Cara Margherita, con codesta domanda, mi fai tirar fuori
il Comune di Fucecchio. Cerca di seguirmi, senza
interrompermi. Prima di tutto esiste un santo solo: S.
Rocco. Vengo chiamato Rocchino per una ragione molto
precisa. Non interrompermi, eh! Devi sapere che fin dal
1400 nella piazza sottostante c’era già un Oratorio di S.
Rocco; ma era talmente piccolo che lo chiamarono S.
Rocchino. Dentro c’entravano a mala pena il prete ed altri
quattro fedeli.
- Perché non hai rammentato il Comune, come mi avevi
anticipato?
- Perché mi hai interrotto, Margherita?
L’Oratorio riprese un po’ di fiato e proseguì:
- Quell’Oratorio l’aveva fatto costruire proprio il
Comune.
- E perché? – intervenne di nuovo la giovane polacca.
- Ché Mario non te l’ha mai detto come mai in tutti i
paesi della Toscana c’era almeno una chiesina dedicata a
S. Rocco ed al suo amico S. Sebastiano?
- No, non gliel’ho mai detto perché soltanto oggi ci siamo
occupati di te – precisai con calma.
- Margherita, a questo punto il discorso si allunga un
po’. Devi sapere che durante tutto il Medioevo e cioè dal
500 al 1500, si verificavano spesso anche in Toscana le
epidemie di peste. S. Rocco e S. Sbastiamo erano stati
proclamati dalla Chiesa i Santi Protettori dalla peste. La
peste visitava spesso anche Fucecchio. Per questo il
Comune aveva fatto costruire in Piazza un oratorio. Il
Comune avrebbe voluto far costruire un Oratorio più
grande, ma in Piazza non c’era più posto disponibile ad
eccezione di quello dove venne murato l’oratorio.
- E come facevano i due Santi a proteggere i fucecchiesi
dalla peste?
- A dire il vero, Margherita, è Dio che protegge le
persone tramite l’intercessione dei Santi. Dio, però –
così ci fanno credere – diventa buono se Gli rivolgiamo
delle preghiere e se Gli offriamo dei sacrifici. E siccome
la Messa è l’offerta di un sacrificio, il Comune fece
costruire quella chiesina per farvi celebrare delle Messe
per rendere più buono Dio che ci avrebbe così protetto
dalla peste.
- Da chi venivano celebrate le Messe?
- Da un cappellano che veniva scelto dal Comune e che
veniva regolarmente pagato con moneta sonante. Ad esempio,
il 5 maggio 1526 venne eletto come cappellano un frate
nero fucecchiese che si chiamava Luca Gherardelli. Gli
venivano corrisposte 7 lire a mese. Il nostro frate doveva
celebrare le Messe sia all’aperto, in Piazza, sia nel
piccolissimo Oratorio, che si trovava in questa Piazza,
specialmente quando le epidemie erano in arrivo.
- Grazie, grazie, grazie! Ho capito che prima di te c’era
un altro oratorio molto piccolo che si trovava in Piazza e
di cui era proprietario il Comune di Fucecchio.
Un fatto nuovo accaduto nel 1595, dieci anni prima che
venisse realizzato l’Oratorio al termine della prima rampa
di scalini.
Mi feci consegnare il cellulare magico a Margherita e,
rivolto all’Oratorio, gli dissi:
- Siccome hai già parlato tanto, ora devi riposarti un
po’. Ci penserò io a fornire alcune informazioni
importanti alla ragazza polacca.
Margherita mi chiese:
- L’Oratorio che si trovava su questo ripiano venne fatto
costruire dalla Compagnia dei Pomponi, vero?
- Dei Pomposi o di S. Rocchino. Devi sapere che questa
Compagnia era nata nel 1595, quando l’oratorio,
piccolissimo, si trovava ancora in Piazza. Questa
Compagnia era stata fondata da un gruppo di Fucecchiesi
ricchi ed acculturati. Decisero di indossare una cappa di
color verde e di reclutare soltanto persone distinte ,
cioè benestanti e istruite. La Compagnia voleva promuovere
una maggiore devozione per i due santi: Rocco e
Sebastiano. Tutti convennero, fin dalla nascita della
Compagnia, che sarebbe stato necessario un Oratorio molto
più grande e che doveva trovarsi nella Piazza o nei suoi
paraggi. Ma dove?
-Scusa, Mario - interloquì Margherita – c’era già nel 1595
questa doppia rampa di scalini?
Di scalini qui non c’era nemmeno l’ombra quando nacque la
Compagnia di S. Rocchino. E in cima alle due rampe non
c’era nemmeno la facciata della Collegiata con il suo
orologio.
-Che cosa c’era allora?
Al posto delle scale c’era un ciglione ricoperto di erba e
di qualche arbusto. Sulla tua sinistra, di fianco al
palazzo – che non c’era - passava un viottolo che portava
sul Poggio Salamartano.
-E in cima alla seconda rampa che cosa c’era?
-C’erano due cose: un bellissimo campanile di cui poi ti
mostrerò l’immagine e la parte posteriore della vecchia
Collegiata. A quel tempo la facciata della Collegiata era
davanti al muro castellano. Poi ti farò vedere anche
questa. Adesso, Margherita, puoi riprendere la
conversazione con l’Oratorio.
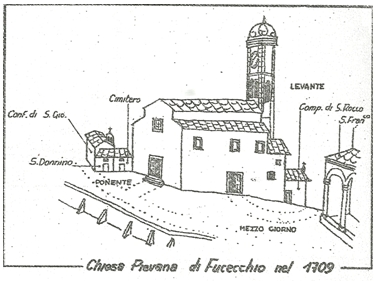
Le passai il cellulare magico.
Come nacque l’Oratorio di S. Rocchino posto fra la
Piazza e il campanile della vecchia Collegiata.
- Ciao, ciao, ciao, Oratorio. Se non ti dispiace
riprendiamo la nostra conversazione. Puoi dirmi quando i
Pomposi decisero di costruire il tuo Oratorio?
- Subito. Appena ebbero fondato la compagnia, nel 1595. Ma
siccome era impossibile trovare un’area grande nella
Piazza, studiarono subito la possibilità di edificare il
nuovo Oratorio sul dirupo o ciglio che si trovava fra la
Piazza ed il campanile della vecchia Collegiata.
- Chi era il proprietario di quel pezzo di terreno?
- Il pievano. A quel tempo la Collegiata si chiamava Pieve
ed il parroco della pieve veniva chiamato pievano.
- E allora che cosa successe? – chiese di nuovo
Margherita.
- I “pomposi” andarono dal pievano e gli chiesero se era
disposto a vender loro quel ciglio per fabbricarci un
Oratorio abbastanza grande di S. Rocchino, visto che
quello di Piazza era inutilizzabile specialmente ora che
era nata la Compagnia di S. Rocchino.
- E il pievano che cosa rispose?
- Quel pievano fu bravissimo. Si chiamava don Guglielmo
Lupi. Lui rispose loro: “Io sono disposto a regalarvelo
quel terreno; però, lo sapete meglio di me, per poter
costruire l’Oratorio è necessaria l’autorizzazione della
nostra episcopessa.
Margherita, in preda ad una discreta dose di perplessità,
protestò:
- Ma tu, Caro Oratorio, ti stai burlando di me. Le
episcopesse non sono mai esistite. Mi fai cader dalle
nuvole. Non scherzare, per piacere!
- Io non sto scherzando e Mario te lo può garantire. Per
piacere, Mario, devi intervenire!
Confermai:
- L’Oratorio sta dicendo la verità. Della badessa di
quelle monache di Gattaiola in Lucca ti ho già parlato
quando ti trovai davanti alla libreria Eden. La chiesa di
Fucecchio è stata governata dalle episcopesse da 1299 fino
al 1622. Soltanto a partire dal 1622 noi siamo stati
governati dai vescovi di S. Miniato.
- Ed allora cosa successe?
L’Oratorio rispose:
- I dirigenti scrissero una lettera alla episcopessa per
chiederle la cessione del terreno e l’autorizzazione a
costruire un Oratorio di S. Rocchino più grande fra la
Piazza e il campanile della pieve..
- E l’episcopessa che cosa rispose?
- L’episcopessa autorizzò la cessione del terreno e la
costruzione dell’Oratorio.
- E poi che cosa successe? – insistette Margherita.
- La Compagnia fece costruire un bell’Oratorio che si
trovava proprio nel luogo dove vi trovate tu e Mario.
Appena l’Oratorio fu terminato, e si era nel 1605, i
Pomposi scrissero un’altra lettera alla episcopessa perché
mandasse un suo vicario a consacrarlo e perché chiarisse a
tutti i confratelli quello che avrebbero potuto fare
nell’Oratorio.
Presi il cellulare dalla mano destra di Margherita e
suggerii all’Oratorio:
- Se te lo ricordi, ripetile quello che scrisse l’episcopessa
ai Pomposi.
- Me lo ricordo molto bene. Scrisse: “Manderò il mio
vicario, don Vincenzo Sisti a consacrare il vostro
Oratorio nella festività della Natività della Beata sempre
Vergine (8 settembre) onde in quello si possino celebrare
divini uffizi e Messe, e che possa seppellirsi i detti
confratelli.”
- Ma era matta quella episcopessa? Sotterrare i morti in
una piccola chiesa è antigienico, non è vero?
- Cara Margherita – intervenni – ricordati che i fatti si
riferiscono al 1600. A quel tempo che se ne sapeva
dell’igiene? Nell’area del Poggio Salamartano c’erano tre
chiese (S. Donnino, pieve di S. Giovanni, S. Salvatore) e
due oratori (Madonna della Croce e S. Rocchino). Ebbene
ogni chiesa ed ogni oratorio disponeva di tombe dentro il
fabbricato e di un cimitero, lì vicino, dove le salme
venivano interrate. Nell’area del Poggio Salamartano
c’erano perciò anche cinque cimiteri. Cara Margherita, noi
avemmo il primo cimitero pubblico, lontano dal paese,
soltanto nel 1786.
- Grazie, Mario, per il tuo intervento chiarificatore –
attestò l’Oratorio
Le ultime domanda di Margherita
- Ma dov’è andato a finire quell’Oratorio che era qui? Chi
mi risponde?
- Ti rispondo io, Margherita - rispose l’Oratorio, che
proseguì – Io rimasi in vita per 117 anni. Poi venni
demolito e finii per sempre.
- Da chi fosti demolito?
- Dall’arciprete della Collegiata nel 1782.
- Dall’arciprete? O che non si vergognò?
- O Margherita, l’arciprete si limitò a dare ai muratori
l’ordine di demolirlo.
- Ma com’è possibile che un prete dia l’ordine di
abbattere una chiesa anche se piccola. E poi questo
Oratorio non era dell’arciprete: era della Compagnia di S.
Rocchino.
- Povera Margherita, si vede che sei digiuna di
informazioni storiche! Devi sapere che due anni prima, e
cioè nel 1780, il Granduca della Toscana Leopoldo I°
soppresse tutte le compagnie che esistevano in Toscana e
quindi anche quelle di Fucecchio. Il Granduca fece poi
un’altra cosetta: regalò tutti i possedimenti delle
compagnie al Capitolo della Collegiata e cioè alla
Collegiata. Nello stesso anno il Capitolo decise costruire
una Collegiata nuova di zecca e con la facciata rivolta
verso la Piazza anziché verso il Monte Pisano. E nel 1782
l’arciprete fece demolire tutta la vecchia Collegiata ed
anche questo Oratorio che era diventato suo. Dov’era il
ciglio avrebbero costruito la scalinata che saliva davanti
al portone della Nuova Collegiata. Perciò quel povero
arciprete non fece alcun dispetto a nessuno. Il mio
oratorio doveva essere abbattuto per forza per far posto
alla scalinata. Soddisfatta?
- Soddisfattissima, Oratorio. Ti chiedo scusa se qualche
volta mi sono mostrata un tantino intemperante.
- Ti capisco, Margherita. Sappi, però, che ti voglio molto
bene e che sento anche il dovere di ringraziarti per
l’interesse che hai dimostrato nei miei confronti. Ti
meriti tanta fortuna e tanti successi. Salutami e
ringraziami il tuo accompagnatore Mario. Ciao.
- Ciao, ciao, ciao, Oratorio di S. Rocchino.
Una dimenticanza imperdonabile
Salimmo sul Poggio Salamartano e, dopo aver disceso le
Scarelle, imboccammo il Viale Buozzi e ci dirigemmo verso
lo stadio comunale.
Per tutto il tragitto non avevamo profferito una parola.
Divertito, punzecchiai Margherita con questa osservazione:
- Tu, Margherita, questa volta ti sei dimenticata di
chiedere una informazione importantissima all’Oratorio di
S. Rocchino.
- Quale informazione?
- Per mezz’ora abbiamo parlato di un santo, ribattezzato
Rocchino e..
- Ah, è vero: ho dimenticato di chiedergli se mi faceva
conoscere la vita di S. Rocco. Tu Mario la conosci? Puoi
raccontarmela?
- Ti dirò soltanto che la festa di S. Rocco cade ogni anno
il 16 agosto. Appena sarò giunto a casa di manderò tramite
la posta elettronica una scheda con la vita di S. Rocco.
Mezz’ora dopo esserci salutati, sul computer di Margherita
comparve il testo della vita di S. Rocco qui riportato.
San Rocco nacque pochi anni prima del 1300 a Montpellier
in Francia.
All'atto della nascita recava sulla pelle del petto una
croce rossa.
Il cognome della sua famiglia era Rog. Da Rog venne
derivato il nome Rocco.
Rocco, a venti anni, rimase orfano di entrambi i genitori.
Subito dopo questo triste evento decise di recarsi in
pellegrinaggio sulle tombe degli apostoli a Roma.
Prima di partire distribuì tutte le sue ricchezze ai
poveri.
Parti con il caratteristico abbigliamento dei pellegrini:
cappello a falde larghe; mantello a mezza gamba o
sarrocchino; il bordone o bastone; un rosario ed una
grossa conchiglia sul petto che fungeva da bicchiere e da
tazza.
Giunto in Italia si trovò di fronte ad una grave epidemia
di peste. Dimentico dello scopo del suo pellegrinaggio, si
dedicò interamente all'assistenza degli appestati.
Anche a Roma il giovane Rocco profuse tutte le sue energie
e tutto il suo spirito di carità nei confronti degli
appestati.
E dopo Roma, andò a Cesena, a Novara e poi a Piacenza per
assistere gli appestati.
Sulle rive del Po il giovane francese contrasse la peste.
Il bubbone, comparsogli su di una gamba, gli procurava
dolori lancinanti.
Per non essere di peso a nessuno si trascinò in un bosco e
si rifugiò in una capanna. Il bubbone, immobilizzandolo,
gli impediva di mangiare e di bere. Accaddero, però, due
fatti prodigiosi:
una fonte cominciò a sgorgare a portata della conchiglia
di S. Rocco ed un cane, tutti i giorni, gli portava un
tozzo di pane stringendolo fra i denti.
Rocco guarì.
Il giovane, allora, ritornò in Francia a Montpellier.
Nessuno lo riconobbe; neppure suo zio che era governatore
della città. E fu proprio lo zio che lo fece arrestare
come spia.
Dopo cinque anni di prigionia, Rocco morì. Era il giorno
dell'Assunta del 1327.
Solo allora i parenti lo riconobbero perché videro sulla
pelle del suo petto la croce rossa che egli vi portava
impressa fin dalla nascita. |