|
<15> LA FORNACE D’ANDREA
Fucecchio, 6 marzo 2012
Verso le ore 14 cominciò a scendere dal cielo nero una
pioggia incredibilmente battente. Dovetti dare l’addio
alla mia camminata quotidiana. Da una scatola da scarpe
tirai fuori una bella manciata di cartoline e di foto. Con
cura mi dilettai a selezionare e ad ordinare cartoline e
foto sulla fornace d’Andrea che si trova sul lato destro
di viale Gramsci per chi si dirige verso il ponte.
Ad un tratto squillò il telefono.
- Pronto, pronto, pronto!
- Ciao, Margherita. Hai bisogno di qualcosa?
- No, volevo soltanto sapere che cosa stai facendo dato
che non puoi andare a camminare a causa della pioggia.
- Sto riordinando cartoline e foto della Fornace d’Andrea,
morta bruciata il 20 settembre 1983 e sotterrata
definitivamente a partire dai primi anni del 2000. Mio
fratello ha documentato la sepoltura di questa fornace con
un kit di fotografie veramente interessanti.
- Posso venire a vedere codeste foto? Verrò da te con la
mia auto. Perciò non mi bagnerò.
- Ti aspetto, Margherita.
- Grazie, grazie, grazie.
Lasciai perdere le cartoline e mi portai al vetro della
finestra del mio studiolo per assistere all’arrivo della
giovane colf polacca.
I miei ricordi del trenino della fornace
A Margherita, per la prima volta in minigonna blu e
scarpette con il mezzo tacco, mostrai la cartolina con la
fornace d’Andrea dietro cui si staglia il panorama di
Fucecchio.
- Ma io questa ciminiera non l’ho mai vista e nemmeno
questo edificio e tutta questa distesa di mattoni!-
osservò Margherita che si era seduta accanto a me davanti
al mio banco di lavoro.
- Cos’era?
- Era una fornace di laterizi, Margherita.
- Non ti capisco, Mario.
- Era un forno dove si cuocevano i mattoni invece che del
pane. E dalla enorme ciminiera uscivano il fumo e i gas di
quel forno.
- Esisteva da tanto tempo questa fornace?
- Nacque nel 1927, cinque anni prima di me. D’estate
venivo quasi tutti i giorni in viale Gramsci. Prima di
tutto mi recavo nel tratto di strada dove si aprono le
buche; poi ritornavo indietro, salivo sull’argine e mi
portavo vicino alle verghe del trenino. Non ti capisco,
Mario.
- Hai perfettamente ragione. In ognuna delle attuali due
buche c’erano gruppetti di operai che con le vanghe
staccavano fette di terra ricche di argilla e le
depositavano in certi vagoncini di ferro non più lunghi di
un metro e larghi una settantina di centimetri. Questi
vagoncini viaggiavano con piccole ruote di ferro su due
verghe come i treni. Appena un vagoncino era colmo di
terra veniva spinto da uno o due operai fino alla base
dell’argine. A questo punto il vagoncino doveva compiere
un tratto in salita lungo una cinquantina di metri. Giunti
alla stazioncina, l’operaio o i due operai attaccavano il
vagoncino ad un cavo di ferro. Il vagoncino veniva
trainato dal cavo dentro la fornace all’altezza del
secondo piano. Io vedevo sparire il vagoncino colmo di
argilla dietro quella porta finestra dell’edificio. E poco
dopo vedevo scendere il vagoncino vuoto fino alla
stazionicina ai piedi dell’argine. Il solito operaio
sganciava il vagoncino dal cavo di ferro e lo spingeva
verso una delle due buche. I nostri genitori chiamavano
questi vagoncini il trenino. Il treno vero, cara
Margherita, nonostante passasse dalla vicina stazione di
S. Miniato, distante un paio di chilometri, io l’ho visto
soltanto a 12 anni.
Margherita in diretta con una cartolina della fornace
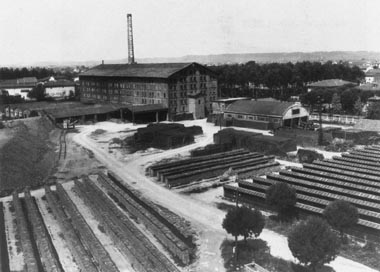
La
fornace D'Andrea (fabbrica dei mattoni)
La giovane colf mi chiese se poteva parlare con la
cartolina. Io le passai il cellulare magico. Margherita si
mise subito in contatto con la fornace.
- Pronto, pronto, pronto, fornace!
- Ciao, Margherita. Mi fa tanto piacere conoscerti. Che
cosa desideri sapere?
- Come mai ti chiami Fornace d’Andrea?
- Perché l’ultimo proprietario della Fornace si chiamava
Rodolfo D’Andrea. Dietro questo proprietario c’è una
storia molto interessante, cara Margherita.
- Davvero? Potresti raccontarmela?
- Ti converrà prendere qualche appunto perché questa
storia è un po’ complicata.
- Li farò prendere a Mario gli appunti. Lui c’è più
abituato. Puoi cominciare.
- Tale fornace, modello Hoffmann, venne fatta costruire
nel 1927 dal signor Raffaello Turchi originario di Siena,
ma da molti anni residente a Fucecchio, in Piazza La
Vergine. Questo signor Turchi possedeva già una fornace in
cima a via delle Fornaci nei pressi di Poggio al Vento. Il
signor Turchi, però, non era nato con la camicia. Pochi
anni dopo aver fatto costruire la bellissima fornace di
Viale Gramsci fu costretto a chiudere la fornace che aveva
sotto Poggio al Vento e a vendere questa veramente bella
fornace di Viale Gramsci.
- E allora che cosa successe?
- Questa fornace venne acquistata da un certo Carlo Vitolo,
originario di Torrita in provincia di Siena. Nel 1939 il
Vutolo si mise in società con il signor Alessandrini,
felicemente sposato e padre di Rodolfo. Qui la matassa si
ingarbuglia, cara Margherita.
- Procedi, procedi: muoio dalla curiosità.
- Nel 1945, subito dopo la fine della guerra, il signor
Alessandrini morì. Il suo posto venne ricoperto dalla
moglie che si rivelò all’altezza della situazione. Due
anni dopo la morte del marito la signora Alessandrini
diventò proprietaria unica della Fornace. A quell’epoca
aveva alle dipendenze ben 130 operai. Un anno dopo, nel
1948, quando gli affari della fornace andavano a gonfie
vele, la vedova Alessandrini di sposò con Roberto D’Andrea
a cui cedette il ruolo di amministratore della fornace.
Roberto d’Andrea si affiancò il figlio della Alessandrini,
Rodolfo, da qualche anno adulto, che rivelò immediatamente
ottime doti manageriali. Ora Margherita devi stare molto
attenta.
- Non preoccuparti. Ti seguo con moltissimo interesse.
- Il secondo marito della Alessandrini si rese subito
conto che il figliastro Rodolfo aveva spiccate attitudini
da manager. Ed anziché ostacolarlo ne favorì con
entusiasmo l’ascesa. Non solo: sarebbe stato
orgogliosissimo di esserne il padre. Una sera propose alla
sposa e a Rodolfo che lui sarebbe stato felicissimo di
dargli il proprio cognome. La vedova ed il figlio
apprezzarono moltissimo il gesto del D’Andrea ed accolsero
la proposta. In breve tempo Rodolfo Alessandrini diventò
Rodolfo d’Andrea. A questo punto la madre ed il patrigno
preferirono uscire dalla scena e si ritirarono a vita
privata. Rodolfo divenne il proprietario ed il manager
della fornace. Gli affari andarono benissimo fino al 6
novembre 1966, il giorno dell’alluvione dell’Arno.
- Che cosa successe di tanto grave? – chiese Margherita?
- L’alluvione danneggiò a tal punto i macchinari della
fornace e le zone di scavo (le “Buche”) da indurre Rodolfo
d’Andrea a chiudere i battenti nel 1970.
La storia della fornace, però non era finita
- Grazie infinite, bellissima cartolina. Non so davvero
come ringraziarti della bellissima storia che mi hai
raccontato.
- Mia cara Margherita, la storia non è ancora finita
perché non ti ho raccontato com’è morta la meravigliosa
fornace.
- Hai ragione. Ero stata davvero sbadata. Raccontami come
finì la fornace Hoffmann.
- Rodolfo D’Andrea dopo aver chiuso la fornace se ne andò
a vivere a Roma con la speranza che qualcuno desiderasse
comprarla per ripristinarla destinandola, magari, ad altri
usi o produzioni.
La fornace, purtroppo, morì la notte del 29 settembre
1983. Un incendio di vastissima estensione distrusse
completamente la fornace. Del grande fabbricato rimasero
in piedi soltanto dei pezzi di muro e la ciminiera.
Sembravano quelli della fornace, i ruderi di un
bombardamento aereo. Il peggio accadde dopo quando l’area
della fornace e del suo piazzale di esposizione dei
laterizi venne dichiarata area fabbricabile. Subito venne
decretata la demolizione dei ruderi. Nel 2005 iniziò la
triturazione di tutto il materiale della demolizione. Poi,
prima del 2010, nell’area dell’ex fornace si cominciarono
a costruire fabbricati abitativi, nonostante le proteste
di alcuni cittadini che avvertivano la necessità di
ricostruire a scopo museale la fornace e la sua ciminiera.
Margherita non poté trattenere le lacrime e piangendo
seppe solo dire:
- Grazie, grazie cartolina. Ciao!
|